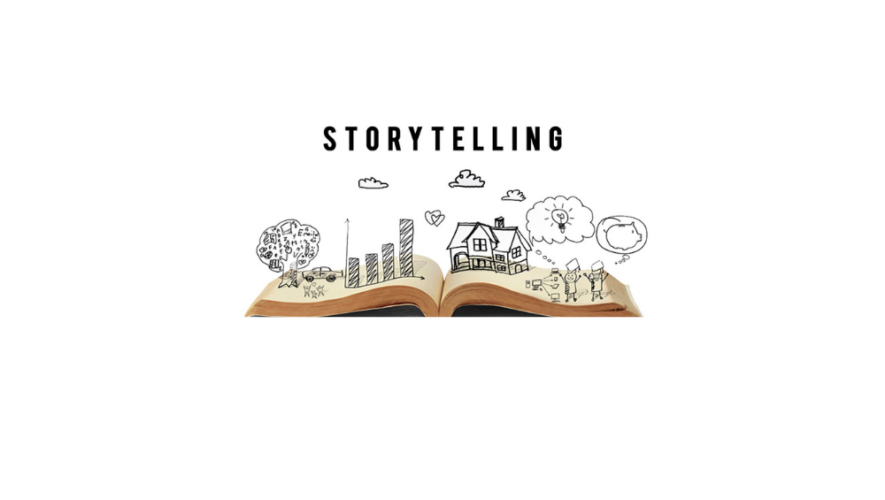AUTORE/TRICE: NAZZARENO LACIDOGNA & SARA BRIANTI,
in collaborazione con il gruppo da 12CFU
Il corso A.A. 2019/2020 di Interactive Storytelling & Art si è proposto come un approfondimento sulla connessione tra due componenti in uno scenario pervaso da piattaforme mediali: interactive e storytelling (Lughi 2015). Lo scopo generale del corso è avvicinare gli/le studenti/sse verso la consapevolezza della possibile percorribilità e modificabilità dei testi. Interactive si declina qui anche come vero e proprio metodo di insegnamento: gli interventi di esperti presenti fisicamente in aula; l’approccio AmA (Ask me Anything) adottato sulle piattaforme; l’introduzione e/o l’effettivo impiego quotidiano di alcune importanti piattaforme digitali, i.e. WordPress, Trello, Infogram, Reddit e HP Reveal. Addentrandoci più approfonditamente nelle nozioni apprese durante il corso, si possono evincere principalmente cinque nuclei: User Generated Content, Transmedia Storytelling, Data Storytelling, Letteratura Interattiva e Urban Storytelling.
Settimana 1 – USER GENERATED CONTENT
Contenuti
La Rivoluzione Industriale implica una suddivisione delle mansioni del lavoro possibile da finanziare grazie all’accumulo secolare di capitale. Siccome i prodotti più diffusi erano anche i meno costosi, i consumatori tendevano a somigliarsi tra loro: la quantità aumentava e la varietà/qualità era scarna. Si procedeva verso un’uniformità dell’offerta, peculiarità presente fino a metà ‘900, e successivamente si sviluppa la Long Tail (Anderson 2006) per la domanda sempre più disomogenea. La nostra epoca è caratterizzata dal passaggio dall’ “editare” al “distribuire”. La Long Tail è quella parte di mercato che somma tutti i singoli prodotti venduti anche poche volte (per le nicchie più effimere). Oggi, le persone pubblicano di tutto sulle piattaforme e il loro obiettivo è raggiungere anche semplicemente un micro-pubblico: i consumatori si sono trasformati in produttori: da consumer a prosumer, individuo che produce contenuti sfruttati poi dall’azienda (Dando così nuova accezione al concetto di feedback: processo per cui l’effetto risultante dall’azione di un sistema si riflette sul sistema stesso per variarne/correggerne opportunamente il funzionamento). Questa user generated culture (Ventura 2015) entra in concorrenza con il lavoro culturale, offrendo gratuitamente ciò che prima veniva venduto. Oggi il self-publishing permette ai messaggi di raggiungere altre nicchie: siamo autori no-profit sia per la produzione che per la diffusione digitale. Oggi tale distinzione non è chiara, come si evince dalla distinzione professione/hobby o lavoro/tempo libero. L’attività di prosuming è instanziabile (in informatica un’istanza è un particolare oggetto di una determinata classe. Ogni istanza è separata dalle altre, ma condivide le sue caratteristiche generali con gli altri oggetti della stessa classe.) in un concetto: i meme, contenuti semi-originali facilmente riproducibili ed indipendenti dalle capacità dell’autore. Il prosumer ha bisogno della piattaforma più di quanto la piattaforma abbia bisogno del prosumer. Far circolare le proprie produzioni è un potenziale investimento per una eventuale carriera (anche se non la si prefigge) nell’industria culturale, si veda il caso degli influencer su Instagram. Come afferma Guy Debord (1967) viviamo ormai in una società dello spettacolo in cui ogni individuo rientra in uno schema di immagini dominanti senza comprendere la propria esistenza, una società senza partecipazione attiva. Tuttavia, il Situazionismo propone una risposta a questa passività: il détournement, ovvero il plagio di elementi preesistenti e il loro utilizzo per il sostegno di una tesi propria, oggi divenuto una vera e propria tecnica di produzione.
Esperti
Raffaele Alberto Ventura è l’autore de La teoria della classe disagiata (2015). Specificamente, durante il corso abbiamo approfondito un capitolo al suo interno intitolato User Generated Culture, in cui si descrive l’evoluzione del consumer verso la figura del prosumer (step contemporaneo di quello che in passato era l’autore, l’artigiano, il membro di una élite, l’indipendente), e l’evoluzione dell’industria culturale: dalla produzione artigianale al nuovo status di piattaforma. A Ventura abbiamo dedicato una sezione specifica su Trello e un post su Facebook, in cui noi studenti/sse gli abbiamo esposto le nostre domande e curiosità, con un importante feedback ricevuto da parte sua.
Piattaforme
TRELLO è la prima piattaforma che è stata introdotta durante le lezioni: è una bacheca interattiva in cui ognun* è liber* di aggiungere, modificare, correggere contenuti propri ed altrui. Le funzioni più interessanti sono la possibilità di: creare una propria sezione personale in cui inserire checklist, documenti, date di scadenza personalizzati e in cui poter ricevere commenti altrui; inserire contenuti di diversi formati, file .doc, .pdf, collegamenti ipertestuali, slide, file immagine e molto altro.
Consegne
Come task, è stato richiesto a ciascun* di stendere un breve elaborato sul concetto di prosumer applicato ad una piattaforma digitale in base al nostro interesse.
Settimana 2 – TRANSMEDIA STORYTELLING
Contenuti
La narrazione transmediale è una forma narrativa che, muovendosi attraverso diversi tipi di media che veicolano nuove e distinte informazioni, contribuisce allo sviluppo della storia e alla comprensione del mondo narrato. L’utente è così chiamato per ricostruire da sé il significato completo della storia. Questo tipo di narrazione prevede: un testo origine di base (fulcro narrativo) che stimola la curiosità nell’approfondire la storia (attraverso pratiche di fandom, siti web, fan-zone), in cui vengono fornite solo alcune informazioni, mentre altre vengono disperse in altre tipologie di testi mediali; e i cosiddetti buchi narrativi (Eco 1979) che definiscono il testo come pigro e che vogliono essere colmati dalla proattività e dall’iniziativa interpretativa del lettore. Non si tratta, tuttavia, di spezzare la narrazione affidando ad ogni medium una parte specifica del racconto, bensì di affidare parte del senso a questi ultimi, catturando così anche varie tipologie di spettatori-user. Il rapporto tra testo origine e derivato è biunivoco e non per forza gerarchico: ciascun testo è collegato agli altri, ma nel contempo può essere usufruito da solo. Direttamente collegato con il concetto di narrazione transmediale, vi è quello di media franchise, ovvero la costruzione di un marchio che viene sfruttato per diversi prodotti dell’industria dello spettacolo e dell’intrattenimento: ogni singolo prodotto va ad incastro con l’altro, progettati tutti in armonia con gli altri prodotti dello stesso franchise. Lo storytelling è qui la risorsa principale per sfruttare una strategia di transmedia marketing. Si parte, dunque, dal racconto di un mondo narrativo per arrivare ad una integrazione della narrazione al consumo su più media. I casi citati a lezione sono The Lost, Matrix, The Lord of the Rings, in cui si prevede un’espansione della narrazione e della diegesi da parte dell’industria e un’attiva partecipazione da parte degli spettatori. In breve, all’interno della narrazione si vedono inseriti anche elementi che Jenkins definisce cultural activator, ovvero delle esche, dei dettagli all’interno della scena di riferimento che stimolano la performatività dell’utente e, quindi, la produzione individuale o collettiva degli utenti. Secondo la teoria di Jenkins, vi sono delle peculiari direttive che ci permettono di comprendere il fenomeno: spreadability (espansione del mondo finzionale) e drillability (approfondimento del mondo finzionale); continuity (assemblaggio dei frammenti) e multiplicity (ricontestualizzazione del senso); immersion (immedesimazione del mondo finzionale nel mondo reale) e extractability (creazione di elementi del mondo finzionale nel mondo reale); world-building (creazione enciclopedica a tutto tondo del mondo finzionale).
A tal proposito, si è parlato di ARG (Alternate Reality Game) nonché un esempio cardine di storytelling transmediale. Questi tipi di game, che seguono diverse linee narrative, si muovono su media differenti passando dai siti web, blog, ai prodotti seriali, fino ad arrivare ad inserirsi nella vita reale. Essi possono essere utilizzati come tecniche di marketing commerciale, come ad esempio Secret Life, oppure per la maggior affiliazione del fandom a un determinato prodotto culturale, ad esempio The Lost o Mr Robot.
Esperti
Gioele Sasso è uno youtuber, in arte Heikudo, che approfondisce il tema attraverso dei video esemplificativi su quelle che sono chiamate ucronie. Si tratta di un gioco di narrazione interattiva basato sulla creazione di alternative storiche; la coerenza di questa storia prende origine dalla nostra e non inserisce elementi avulsi dalla realtà storica. È una composizione che rispetta sia la continuity che la molteplicità, la continuità nasce dalla molteplicità, poiché nasce dagli interventi degli utenti.
Alessandra Richetti, invece, ci introduce una sua infografica sui fandom, quella del mondo di Frozen relazionato alla tematica LGBT+ e propone uno spunto di riflessione sul fandom come moderno agit-prop citando l’odierno attivismo mediatico volto alla rottura dello schema narrativo filmico canonico per cui i gay e le lesbiche nei film, in passato, venivano quasi sempre uccisi, il ché creava (all’interno della comunità sopracitata) un senso di frustrazione e rabbia.
Piattaforme
Con l’introduzione a REDDIT è stata spiegata l’importanza dei social network per le nicchie di fan per scoprire i segreti e gli indizi che si nascondono nella linea narrativa di Mr Robot. Si é anche delineata una sorta di gerarchia autoriale tra Twitter, usato dai componenti delle Writers Room per diffondere contenuti “Canon”, ovvero uffficializzati dagli autori, e Reddit, usato dagli hardcore fan per diffondere i propri contributi e generare le loro narrative derivate.
Consegne
Come task, ci è stato richiesto di: stendere un breve elaborato sul concetto di digital reputation (dopo aver letto il saggio di Origgi intitolato What is reputation?) applicato ad una piattaforma digitale in base al nostro interesse; di riunire, tramite un apposito file Excel e successivamente tramite l’uso di Infogram, tutti i vari indizi presenti nelle stagioni della serie TV Mr Robot; di stendere un elaborato su una case history di ARG, dopo aver approfondito con la lettura Design Tactics for Authentic Interactive Fiction di Bonsignore, Moulder, Neustaedter, Hansen, Kraus e Druin.
Settimana 3 – DATA STORYTELLING
Contenuti
Il Data Storytelling è la capacità di raccontare una storia attraverso i dati, basandosi sul principio di data visualization. Esso si basa sulla produzione di immagini che comunichino ai destinatari le relazioni tra i dati rappresentati e le immagini. Questa comunicazione è ottenuta attraverso l’uso di una mappatura sistematica tra segni grafici e valori dei dati, utilizzati nella creazione della visualizzazione. La mappatura stabilisce come i valori dei dati verranno rappresentati visivamente, determinando come e in che misura una proprietà di un segno grafico, come dimensione o colore, possa cambiare per riflettere il cambiamento nel valore di un dato. Utilizzando elementi visivi come grafici e mappe, la visualizzazione dei dati è un modo accessibile per vedere e comprendere tendenze, valori anomali e modelli nei dati. Nel mondo dei big data, gli strumenti e le tecnologie di data visualization sono essenziali per analizzare enormi quantità di informazioni e prendere decisioni data oriented. Per capire come funziona la data visualization e come rappresentare correttamente i dati è bene conoscere le principali modalità di rappresentazione dei dati.
Fondamentalmente esistono quattro tipi di presentazione di base che si possono utilizzare per presentare i dati:
– Relazione: cerca di mostrare una connessione o una correlazione tra due o più variabili attraverso i dati presentati
– Confronto: cerca di distinguere un insieme di variabili da un altro mostrandone il valore totale
– Composizione: cerca di raccogliere diversi tipi di informazioni al fine di raggrupparli e visualizzarli insieme
– Distribuzione: cerca di delineare una raccolta di informazioni collegate più o meno tra di loro per capire il tipo di interazione tra le variabili
La visualizzazione grafica dei dati è un’operazione piuttosto antica: ne abbiamo un esempio da Goethe con La Teoria dei Colori (1810), in cui tramite un grafico, che prende il titolo di Ruota Cromatica, spiegò le variazioni cromatiche e i diversi fenomeni ottici. Un’altra importante infografica è quella di Charles Joseph Minard, nel 1845, con la rappresentazione della Campagna di Russia di Napoleone. Minard ha rappresentato, in un’unica immagine bidimensionale, sei variabili: il numero di soldati, le temperature, percorso delle truppe, latitudine, longitudine e flusso temporale.
Nel campo della letteratura, un importante contributo è stato dato da Franco Moretti con il suo libro La Letteratura Vista da Lontano (2015). In fitto dialogo fra parole e immagini, questo libro si propone di avvicinare la storia letteraria alle scienze umane, applicando allo studio della letteratura strumenti e modelli elaborati in altri ambiti di ricerca: i grafici della storia quantitativa, le mappe della geografia e gli alberi genealogici della teoria dell’evoluzione. Figura dopo figura, i grafici, le carte e gli alberi mettono letteralmente davanti agli occhi del lettore quanto sia sterminato e ancora in gran parte inesplorato il campo letterario, incoraggiando così un atteggiamento sperimentale nei suoi confronti: invece di lavorare su questioni di cui di fatto si sa già la risposta, affrontare problemi che non hanno (ancora) soluzione, e ragionarci su finché non se ne viene a capo.
Tra il settembre del 2004 e il settembre del 2005, due designer – Giorgia Lupi e Stefanie Posavec – si sono scambiate un totale di 104 cartoline in modo da raccontare la propria vita l’una all’altra. Le autrici hanno pensato di raccogliere dati, così come si fa per calcolare le statistiche, al fine di ricavarne i relativi grafici. L’idea geniale, però, è un’altra: non hanno utilizzato la solita rappresentazione grafica dei dati, bensì quella che – dopo questo progetto – ha preso il nome di Dear Data. Le cartoline, infatti, raccolgono informazioni anche molto private e mostrano quante cose si possono capire di una persona osservando con precisione piccoli aspetti della sua vita. Le scelte grafiche raccontano loro stesse qualcosa delle due designer, che hanno stili diversi, sia nel tratto che nel modo di rappresentare i dati. Nel 2016 le cartoline sono confluite in un unico libro che, in modo colorato e divertente da decifrare, mostra la vita – anche molto in dettaglio – delle due designer.
Esperti
Indaco Biazzo è venuto a lezione per presentarci il suo progetto basato proprio sulla rappresentazione grafica di dati. City Chrone nasce come uno studio scientifico sui trasporti pubblici e il loro funzionamento nelle varie città. Indaco Biazzo si è servito dei big data, ovvero una raccolta di dati così estesa in termini di volume, velocità e varietà da richiedere tecnologie e metodi analitici specifici per l’estrazione di valore o conoscenza. Infatti, lo scopo della ricerca è quello di poter lasciare gli utenti liberi di navigare nel sito, in cui non solo possono visualizzare tutte le reti pubbliche di trasporti nelle varie città, ma anche dandogli la possibilità di ridisegnare nuove linee e di verificarne gli impatti nella città.
Piattaforme
INFOGRAM: è un software di infografica. Consente alle persone di creare e condividere grafici digitali, infografiche e mappe. Infogram offre un editor WYSIWYG intuitivo, il quale converte i dati degli utenti in infografiche che possono essere pubblicate, incorporate o condivise. Gli utenti non hanno bisogno di competenze di programmazione per utilizzare questo strumento. Uno degli esempi presentati a lezione è il video World War 2: esso ricrea la grandezza numerica dei morti durante la Seconda guerra mondiale. È stato creato in maniera tale da dare un impatto più realistico e consapevole della gravità dell’accaduto in numero di morti. Infogram è stato, inoltre, utilizzato dagli studenti al fine di ricostruire la timeline grafica dell’ARG di Mr. Robot e per delineare il lavoro che è stato svolto, a gruppi, per la creazione di un ARG (CFU: Come Fregare Unito).
Consegne
Durante la settimana di Data Storytelling agli studenti è stato affidato proprio il compito di replicare, in coppie, il lavoro svolto da Giorgia e Stefanie. Il risultato è stato molto eclettico, perché ha messo l’accento sulle differenze tra le varie persone: chi in modo più creativo, chi in modo più schematico, l’obiettivo era quello di scegliere un tema e raccogliere i dati relativi per una settimana. Il risultato di questo lavoro sarà una mostra – organizzata proprio dagli studenti – in cui verranno esposti tutti i lavori e in cui sarà richiesta la partecipazione attiva dello spettatore che, anche lui, andrà a disegnare il proprio Dear Data.
Settimana 4 – LETTERATURA INTERATTIVA
Contenuti
Aarseth (1997) definisce il cybertext come una prospettiva su tutte le forme di testualità per includere fenomeni che oggi sono percepiti come al di fuori o emarginati dal campo della letteratura. L’autore delinea sette criteri degli oggetti testuali in un contesto interattivo digitale: dinamicità, determinabilità, transienza, prospettiva, accesso, linking e funzioni dell’utente. Questi conferiscono al lettore-utente un ruolo attivo nel processo di creazione di significato. Inoltre, egli definisce una letteratura ergodica ponendosi nella prospettiva del lettore performando una specifica azione volta alla generazione di una sequenza letteraria (transienza/ intransienza), e sostiene che, in quanto lettore, si possono distinguere due parti del testo: scriptons (ciò che si manifesta al lettore) e textons (ciò che è celato al lettore).
I Ching (X secolo a.C.) e Calligrammes (1918) di Apollinaire sono esempi propedeutici all’estetica e alle dinamiche testuali tipiche della letteratura digitale oggi declinata in molteplici forme e generi: testi collaborativi di narrativa corale, poesia e prosa generata attraverso il computer, ipertesto e videogiochi.
La ricerca innovativa di nuove strutture e schemi da impiegare durante il processo creativo delle opere venne teorizzata nel 1960 dall’OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle) gruppo fondato da Queneau e Le Lionnais insieme a Perec, Calvino ed Eco. Nel 1947 Queneau pubblica Esercizi di Stile, una collezione di novantanove racconti della stessa storia, rivisitata ogni volta in uno stile differente, e nel 1961 pubblica Cent Mille Milliards de Poèmes, un libro interattivo generatore di poesie che stimola un’azione combinatoria casuale da parte del lettore.
Le opere di Perec si basano, invece, sull’utilizzo di limitazioni (contraints) formali, letterarie o matematiche. I vincoli sono utilizzati come strumenti per stimolare le idee e l’ispirazione dello scrittore-lettore; tra i più rilevanti, la macchina crea-storie da lui impiegata nella costruzione del romanzo La Scomparsa, un lipogramma ove non compare mai la lettera e.
Italo Calvino pubblica Se una notte di inverno un viaggiatore (1979) in cui definisce l’iper-romanzo come luogo di infiniti universi contemporanei in cui tutte le possibilità vengono realizzate in tutte le combinazioni possibili. Le sue parti sviluppano nei modi più diversi un nucleo comune agiscono su una cornice che li determina e ne è determinata, acquisendo a pieno titolo lo status di romanzo con caratteristiche superiori alla norma, oltre i normali romanzi e che funziona come macchina per moltiplicare le narrazioni costruito da molte storie che si intersecano.
Sotteso alla struttura del web vi è l’ipertesto: un insieme di frammenti (lessie) di varia natura (testuale, visuale, auditiva e audiovisiva), messi in relazione tra loro per mezzo di parole chiave (nodi), connessioni logiche e rimandi (link), che consentono all’utente di costruirsi un non programmato e autonomo percorso di lettura. A tal proposito, J.J. Abrams (con S. La nave di Teseo) incontra una realtà esterna para-testuale che intende provocare una reazione alla sfida posta sul piano della letto-scrittura analitica andando oltre i confini materiali e tradizionali propri della pagina. Un libro a bivi (o librogame) è un’opera narrativa che, a partire dagli anni Ottanta, ha rappresentato un’affascinante alternativa alla tipica lettura lineare coinvolgendo, all’inizio della narrazione, un pubblico di lettori eterogeneo (o lo stesso lettore in occasione di una rilettura) nel compimento di scelte volte a condizionare lo svolgimento e lo snodo della trama.
Esperti
Fabrizio Venerandi, con il progetto editoriale di Quinta di Copertina, ha prodotto un corpus originale di testi interattivi e parametrici. Il suo ebook Poesie Elettroniche comprende, ad esempio, poesie che cambiano a seconda del tempo (sole, pioggia, giorno, notte), alcune poesie che spariscono mentre si leggono, altre che hanno una configurazione interattiva ed animata ad albero concettuale.
Piattaforme
Nei primi anni 2000, si afferma WORDPRESS, una piattaforma-software di blogging e content management system (CMS) open source che consente la creazione e distribuzione di un sito Internet formato da contenuti testuali o multimediali, facilmente gestibili e aggiornabili in maniera dinamica secondo una struttura gerarchica collaborativa.
Consegne
Upload su WordPress di: un approfondimento su un tema a scelta dell* studente/ssa (facoltativo), in singolo o con altr* collegh*; Dear Data del proprio team; una restituzione in gruppo dei lavori su prosumer e reputation in base all’oggetto/piattaforma analizzati in precedenza.
SETTIMANA 5 – URBAN STORYTELLING
Contenuti
L’Urban Storytelling é concettualmente collegato alla pratica situazionista della psicogeografia. Con questo termine si intende una metodologia d’indagine dello spazio urbano creata nei primi anni cinquanta dal movimento di avanguardia artistica dei lettristi. Nel primo numero del bollettino dell’Internazionale Situazionista, pubblicato nel 1958, la psicogeografia viene definita come lo studio degli effetti precisi dell’ambiente geografico, disposto coscientemente o meno, che agisce direttamente sul comportamento affettivo degli individui. In questo senso la psicogeografia si inserisce nel filone del determinismo ambientale, che era nato già con Friedrich Ratzel a metà Ottocento, per cui le relazioni tra ambiente e natura sono considerate e analizzate in maniera univoca, ovvero dalla natura/architettura all’uomo e non viceversa. L’idea promossa da questa teoria è la decostruzione degli spazi urbani e la costruzione di nuovi, le cui caratteristiche principali sono: essere di breve durata, in mutazione permanente e con la possibilità di mobilità. La psicogeografia studia le correlazioni tra psiche e ambiente, assumendo caratteri sovversivi nei confronti della geografia classica e ponendo al centro dei suoi scopi la ri-definizione creativa degli spazi urbani.
La psicogeografia è un gioco e allo stesso tempo un metodo efficace per determinare le forme più adatte di decostruzione di una particolare zona metropolitana. La tecnica dell’esplorazione psicogeografica è la deriva, che indica un passaggio improvvisato attraverso ambienti diversi. A concettualizare la deriva come tale fu Guy Debord, il quale nel 1956 ne fornisce alcune indicazioni fondamentali:
«Per fare una deriva, andate in giro a piedi senza meta od orario. Scegliete man mano il percorso non in base a ciò che sapete, ma in base a ciò che vedete intorno. Dovete essere straniati e guardare ogni cosa come se fosse la prima volta. Un modo per agevolarlo è camminare con passo cadenzato e sguardo leggermente inclinato verso l’alto, in modo da portare al centro del campo visivo l’architettura e lasciare il piano stradale al margine inferiore della vista. Dovete percepire lo spazio come un insieme unitario e lasciarvi attrarre dai particolari»
Così, secondo Debord, il perdersi in una città è alla base della deriva psicogeografica. L’origine di questo ambito è da ricercarsi nelle trasformazioni a cui la città è perennemente sottoposta e, di conseguenza, il rapporto che tale spazio ha con la psiche dell’individuo. Possiamo intendere la psicogeografia come una tecnica del corpo, la quale indaga lo spazio urbano tramite lo spostamento a piedi. La ridefinizione dello spazio urbano avviene tramite l’enfatizzazione del comportamento ludico, in modo da permettere agli individui di costruire in modo strettamente creativo i nuovi spazi.
È anche in questo scenario che si sviluppano le tecnologie di AR (Augmented Reality) e ARG (Alternate Reality Game): un gioco che collega Internet al mondo reale, che prendiamo qui in considerazione per quanto riguarda la creazione di un gioco virtuale all’interno di uno spazio urbano, reale e concreto.
Esperti
Matteo de Simone ingegnere del software ed esperto di domotica, ci ha parlato della relazione che può crearsi tra essere umano e software. Infatti, nel momento in cui devo costruire un ambiente che interagisca con me, non solo devo usare lo storytelling per raccontare bene quello che accadrà nell’ambiente circostante, ma tale interazione deve essere supportata anche da un impianto tecnologico. Per fare un esempio, chiedere ad Alexa di spegnere luce, crea un legame con il software che non è lo stesso rispetto all’atto di alzarsi e spegnere l’interruttore. È importante approcciarsi alla programmazione per comprendere le potenzialità dello strumento.
Piattaforme
HP REVEAL è una piattaforma tramite cui si può cambiare il mondo interagendo con esso. Rende facile per chiunque creare e utilizzare AR, da educatori che insegnano ai marchi leader a livello mondiale. Essa crea esperienze di brand coinvolgenti in realtà aumentata. È infatti un’applicazione di realtà aumentata che permette di impostare immagini e foto come trigger per far apparire cose interessanti sullo schermo del tablet o dello smartphone tramite la videocamera.
Consegne
Durante questa settimana, è stato chiesto agli studenti la creazione di un ARG che prendesse in considerazione il mondo esterno. È stato dunque pensato un gioco capace di mischiare reale e virtuale tra gli spazi interni e circostanti alla stessa università. Un gioco a tappe, in cui gli studenti – magari da poco immatricolati – avrebbero potuto conoscere, in modo divertente e dinamico, il mondo universitario di Torino. Il progetto ha preso il titolo di CFU: Come Fregare Unito.
Per avere un esempio di quanto svolto, ecco qui il link all’infogram preparato dai ragazzi con le varie tappe e giochi interattivi e non!